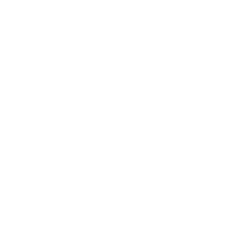Palla al Centro, si ricomincia.
Le Aspirazioni, possono fare la differenza.
Curinga 02-10-2009 La terza giornata di campionato di prima categoria, offre: due anticipi (Sporting Davoli – Nuova Polisportiva Acconia e, Uesse Catanzaro – Real Pianopoli); due incontri impegnativi (Badolato – Nuova Filadelfia e Serrese – Petrizzi); due incontri, sulla carta facili (Ansel Acconia – San Calogero e, Euro Girifalco – Nuova Valle); infine, due incontri con possibili sorprese finali (Nuova Limbadi – Bivongi e Filogaso – Nuova Curinga). Tra Sporting Davoli e Polisportiva Acconia, se si guarda la classifica generale e le “goleade” precedenti della squadra di casa, sembra non esserci scampo per gli ospiti ma, viste anche le buone prestazioni della squadra di Mister Fioretti, il risultato non sembra più scontato fin dall’inizio della gara. Per la Uesse Catanzaro, partita già col piede sbagliato (due sconfitte in due partite giocate), è arrivato il momento di svegliarsi e cercare di conquistare punti, se non vuol fare la stessa fine dell’anno scorso quando, è retrocessa dopo aver perso i Play-Out. Il Real Pianopoli, dal canto suo, non può stare a guardare anche perché, i punti guadagnati fuori casa, alla fine, sono proprio quelli che fanno la differenza. Partita impegnativa è quella tra Badolato e Nuova Filadelfia, che darà la misura della forza della squadra di casa e, in contemporanea, la giusta collocazione della squadra ospite. Certo è che, se la Nuova Filadelfia vuole essere protagonista, così come lo è stata lo scorso campionato, allora, per i ragazzi di Mister Alessandro, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e cercare di fare risultato anche a Badolato dove, apparentemente, sembra impossibile. Il Petrizzi, affronta anche lei una partita impegnativa e, confida di iniziare il suo campionato magari, con un risultato positivo, anche perché è il suo debutto in campionato, visto che, fino ad ora, non ha potuto sostenere nessuna delle sue partite ufficiali. La Serrese, sicuramente, cercherà di mantenere la testa della classifica generale a punteggio pieno, poi, sul campo, ci sarà da lottare per ottenere questo. Sulla carta, facile impegno dell’Ansel Acconia contro il San Calogero, fermo ancora, in fondo alla classifica, a zero punti. All’Ansel, fino ad ora, non è mai mancato il bel gioco anche se, a Pianopoli ne è uscita sconfitta. Se Orlando, Arcuri e Di Cello, fino ad ora troppo spreconi, sono in vena di segnare e ne avranno voglia, allora, il San Calogero dovrà rimandare alla prossima le speranze di vittoria. Tra Euro Girifalco e Nuova Valle, viste le performance della squadra locale, soprattutto quando gioca in casa, non ci dovrebbero essere dubbi sul risultato finale e, speranze per la squadra ospite, anche perché, la Nuova Valle, fino ad ora, non ha rivelato grandi qualità o, particolari aspirazioni. Le partite con possibile sorpresa finale, a mio parere, sono quelle che si giocheranno tra Limbadi e Bivongi e, Filogaso e Nuova Curinga. Il Limbadi ha stentatamente vinto la prima partita di campionato e, non ha potuto disputare la seconda mentre, al contrario, il Bivongi, non ha disputato la prima ed ha perso malamente la seconda. Squadre quindi, alla verifica e, risultato che si conquista sul campo. Nella partita di S. Onofrio, che la Nuova Curinga dovrà disputare contro il Filogaso, si presenta per gli ospiti l’opportunità di un tentativo di fuga. Se sarà rispettata la tradizione, che ha visto fino ad ora la Nuova Curinga uscire sempre con risultato positivo dagli scontri sostenuti contro il Filogaso, allora, il risultato non potrà che essere a suo favore. Del resto, mentre il Filogaso può contare solo sull’apporto dei suoi tifosi e, sul vantaggio del campo amico, la Nuova Curinga può puntare sulla qualità dei suoi giocatori e sulle aspirazioni che, in campo fanno sempre la differenza. Di ciò è consapevole anche il Filogaso e, per questo, ce la metterà tutta per fermare la capolista. La classifica, per ora dà ragione alla Nuova Curinga, domenica sera, il campo avrà stabilito forse, quale delle due ragioni ha prevalso. Er. Ga.
FILOGASO 3 – 1 N. CURINGA
ASD FILOGASO: Vallone A., Valotta R.F., Galati F,, Pannace R, Carnovale A., Sisi D., Caputo L.,Imineo F., Arona N., Mancuso G., Valotta R.,
In panchina: La Neve, Augurusa, Liber to G.
Allenatore: Bruni Vincenzo.
MARCATORI: al 7’pt Valotta R. (F), al 21 ‘pt Mancuso G. (F), al 44’pt Tuoto C. (NC), al 34’ st Imineo F.(F)
ARBITRO: Caricato di Cosenza
ASD NUOVA CURINGA. Sorrentino N., Currado D., Pettinato N, Martinez K., Cerra V., Camillo’ F., Zerbonia S., Tuoto C., Fraglia A., Marturano M., Serratore A.,
In panchina:Grandinetti F., Nosdeo C., Schiavello A., Grandinetti G. La Fortuna C., Colacchio F. Gigliotti A.
Allenatore: Spina Mario.
Filogaso senza pietà Tris alla N. Curinga
FILOGASO 4-10-2009 – Il Filogaso batte in casa la Nuova Curinga. Partita avvincente che ha entusiasmato gli spettatori presenti. I padroni di casa mostrano subito una buona tecnica, molti gli schemi da manuale portati avanti dai ragazzi di Bruni che non hanno mancato di grinta e caparbietà. Valotta va subito a segno dopo uno splendido assist di Mancuso. Al 21 ‘ è già due a zero grazie a Mancuso. A nulla serve il gol della bandiera di Tuoto, visto che nella ripresa Imineo sigla il tris.
Il Quotidiano della Calabria
Ansel Acconia 4 – 1 San Calogero
ANSEL ACCONIA: Matarazzo, Muraca S., Colloca, Michienzi, Mercuri G. , Frijia, Perugino, Orlando, Morelli, Arcuri, Di Cello L.,
In Panchina: Buccafurni ,Muraca L., Mazzotta, Perri G., Vasta, Torcasio F.
Allenatore: Galeoto
ARBITRO: Barca da Taurianova.
Marcatori: 1′ 15′ p.t. Arcuri;22′ p.t. DiCello; 25′ s.t. Orlando; 40′ s.t. Grillo (rig.)
SAN CALOGERO: Prestia L., Prestia G., Pontoriero G., Mazzeo, Colloca, Monteleone G., Mazzitelli G., Marchese, Pata, Grillo, Monteleone A.
In Panchina: Orfanò, contartese, DeVita, Pontoriero G., Galati, Ventrico, Monteleone S.
Allenatore. Romano
Acconia travolgente Pratica subito archiviata
di BRUNO SODARO CURINGA – Tutto facile per la compagine di Acconia. Passa subito in vantaggio dopo 40 secondi dall’inizio gara. Assist di Di Cello per Arcuri che batte il portiere ospite; Passano dieci minuti è lo stesso giocatore raddoppia, dopo aver ricevuto da Di Cello. La terza rete, al 26′ con Di Cello su passaggio di Morelli. Nella ripresa è Orlando a realizzare la quarta rete, n rigore trasformato da Grillo, non rende meno pesante il risultato. Penalty concesso per un fallo di mani.
Il Quotidiano
Ed è subito Gol
Curinga 4-10-2009 Ed è subito Gol. Sono appena trascorsi 30 secondi e, l’Ansel delle meraviglie, è già in gol. Merito ancora una volta del suo uomo migliore, Antonio Arcuri, che con la sua doppietta personale ha, ancora una volta, fatto la differenza tra le due squadre in campo. Un’Ansel ben messa in campo da Mister Calioto, con una difesa compatta ed unita ed un tridente che, ha reso la vita impossibile al portiere avversario, tartassato e sollecitato costantemente , con tiri che arrivavano da tutte le posizioni. Merito anche del Mister quindi, se l’Ansel ha sostenuto una partita di elevato livello perchè, gli avversari, nonostante il risultato fosse di quelli pesanti, si sono comportati egregiamente sul campo con un effetto squadra lodevole ma, con individualità non all’altezza. Voglio dire che, la squadra del San Calogero ha, nonostante tutto sostenuto una buona gara ma, contro l’Ansel, oggi, c’era poco da fare. Un 4-4-2 che si trasformava, ad esigenza, in 4-3-3, con Arcuri a ridosso delle due punte avanzate Orlando e Di Cello, e con Morello a fare da raccordo tra difesa e centrocampo. Un centrocampo supportato da un ottimo Perugino che, finalmente, ha trovato collocazione giusta sul campo di gioco. Michienzi è stato il solito instancabile interditore (l’uomo tatticamente più importante), con alle spalle una difesa solida sia sugli esterni che sulla linea centrale. Le migliori cose le ha fatte vedere, in ogni caso il trio d’attacco, andando a rete ben quattro volte e, con tre uomini diversi. Orlando ha, finalmente, trovato la via della rete, e lo ha fatto con un pallonetto esemplare sul portiere in uscita. Oggi ha dimostrato di avere voglia di fare, lottando su ogni pallone, aggredendo e recuperando posizione come faceva nei suoi momenti migliori. Sembrava una maledizione perchè, ad ogni suo tiro in porta, ci doveva essere sempre qualcosa che impedisse la rete. Poi, nel secondo tempo, quando ha finalmente segnato la sua prima rete stagionale, si è sfogato esultando in modo inequivocabile contro la sfortuna che lo perseguitava fin dalla prima di campionato. La cronaca ha visto l’Ansel pericolosa fin dalla prima azione di gioco; nella seconda, dopo appena 30 secondi, Arcuri, con la sua riconosciuta classe, perfora per la prima volta il portiere ospite. Si verificano poi due episodi dubbi da rigore, la prima a favore del San Calogero e, la seconda per i locali ma, l’arbitro, nel complesso sufficiente, ha negato l’evidenza sorvolando in entrambi i casi. Arriva al 15′ la seconda rete, ancora di Arcuri, che sfrutta la sua esperienza insaccando con una difesa praticamente ferma. La reazione degli ospiti si manifesta solo su tiri piazzati che, impensieriscono poco il debuttante portiere Matarazzo. Prima della chiusura del tempo, è Di Cello ad andare a rete portando a tre le reti di vantaggio. Il secondo tempo non cambia nel ritmo e nella impostazione della partita. Girandola di sostituzioni ma, la musica non cambia. Si macina gioco da ambo le parti, lo stesso gioco diventa più maschio ma, a fare le spese è ancora una volta il San Calogero che subisce la quarta rete, ad opera di Orlando. Il 4-0 ci sta tutto perchè, la superiorità in campo da parte dei locali è evidentissima. Il San Calogero segna la rete della bandiera su calcio di rigore, per fallo di mani in area di Muraca. Ottima l’esecuzione di Grillo che, spiazza il portiere segnando il definitivo 4-1.
Er. Ga.
SPORTING DAVOLI 1 – 1 POL. ACCONIA
SPORTING DAVOLI: Chiefari, Squillacioti, Caporale L., Maiolo (4( st Pugliese), Gangale, Voci, Caporale D. (21′ st Coniglio), Guido, Gualtieri, Fiorenza (35′ st Polimeno), Papaleo.
In panchina: Corasaniti, Colubriale Al, Cosentino, Colubriale An.
Allenatore: Pilato.
MARCATORI: 45′ pt Caporale D. (D), 5′ st Muraca D. (A).
POL. ACCONIA : Oscuro, Serratore, Mastroianni, Muraca D., Pingitore, Neri (1 st Chiodo), Muraca V., Condoleo, Landolfi, Trovato F., Dell’Aquila (30′ st Trovato V.).
In panchina: Guzzi, Carchedi A., Piraina, Panzarella, Catanzaro.
Allenatore: Fioretti.
ARBITRO: Lafandi di Locri.
NOTE: Ammoniti Caporale D. (D)e Muraca D. (A).
Poche emozioni a Davoli Pareggio che accontenta
DAVOLI – 4-10-2009- Finisce con una rete per parte fra Davoli e Acconia. Una gara che, pur avendo una supremazia territoriale dei locali, poche le azioni da rete costruite dalla squadra di mister Pilato. Sul finire della prima parte della gara, Sporting in vantaggio. Papaleo, sulla fascia di sinistra raccoglie un rilancio del portiere Chiefari. Assist per Domenico Caporale, che mette in fondo al sacco. Il pareggio nella ripresa. Dopo cinque minuti Muraca D. lascia partire una parabola, dal limite area di destra, che termina nel set.
b.s.
Il uotidiano
A palle Ferme
La Serrese continua la sua corsa.
Nuova Curinga e Badolato, primo Stop del Campionato.
Ansel che avanza a suon di gol.
Curinga 06-10-2009 Chi ha letto l’articolo di venerdì scorso, pubblicato sul nostro sito, ha potuto constatare che, le previsioni sulle partite relative alla terza di campionato, si sono quasi tutte interamente verificate. Erano state pronosticate due partite facili ( E. Gimigliano – Nuova Valle e Ansel Acconia – San Calogero), e così è stato perchè l’Euro Girifalco, ha vinto facile sulla Nuova Valle e l’Ansel Acconia, ha piegato, a suon di gol, il San Calogero. Erano state previste due partite difficili ( Badolato – Nuova Filadelfia e Serrese – Petrizzi) e, lo sono state perchè, la Serrese ha avuto ragione del Petrizzi, solo nel secondo tempo e, a soli quindici minuti dalla fine, mentre la Nuova Filadelfia, per far suo il risultato, ha dovuto sudare le famose “sette camicie”. Del resto, il Badolato aveva già conquistato sei punti mentre gli ospiti, dopo le sconfitte in Coppa Calabria e la sconfitta pesante racimolata a Davoli, doveva necessariamente vincere per far capire che, ciò che ha fatto lo scorso campionato, non è stato casuale ma, frutto di programmazione e, voglia di arrivare fino in fondo. Tra le due partite previste con possibile sorpresa, c’era anche la Nuova Curinga e, così è stato perchè perdente e, in modo non esaltante a, Filogaso. In effetti, non fa tanto clamore la sconfitta, perchè prima o poi deve arrivare ma, l’entità del risultato finale che, da uomini come Sorrentino, Pettinato, Cerra e Camillò, uomini di riconosciuta esperienza, i tifosi, non se la sarebbero mai aspettata. L’altra partita ( Nuova Limbadi – Bivongi P.), pronosticata come seconda possibile sorpresa, ha visto la vittoria dei padroni di casa ma, non senza difficoltà. Dei due anticipi di sabato, spicca il pari, meritato, conquistato dalla Polisportiva Acconia a Davoli, cioè su un campo, dove, la pur forte Nuova Filadelfia, aveva subito una sconfitta clamorosa incassando ben cinque reti. Nel complesso, quindi, escludendo la Serrese che continua la sua corsa con tre vittorie su tre partite giocate, per le altre, c’è ancora molto da fare e da rivedere. Fa piacere l’impresa della Nuova Filadelfia a Badolato, così come fa piacere l’exploit dell’Ansel Acconia e il buon comportamento, in termini di gioco, della Polisportiva Acconia. Auguriamo continuità di risultati alla Nuova Curinga e, con questi propositi, speriamo di assistere ad un campionato che parli sempre più il dialetto curinghese.
Er. Ga.
Palla al Centro, si ricomincia.
Tra incontri inediti (Nuova Curinga – Nuova Limbadi) e,
derby da godersi (Nuova Filadelfia – Ansel Acconia).
Curinga 09-10-2009 Il campionato riprende domenica con la Serrese capolista, a punteggio pieno; con le squadre pronosticate favorite, come il Badolato e La Nuova Curinga già a rincorrere; con la Nuova Filadelfia che è tornata a fare paura e, infine, con due curinghesi su tre a rincorrere posizioni di prestigio. Andando con ordine, la Serrese, squadra attualmente più in forma del campionato, farà visita al Bivongi e, potrà ancora una volta uscirne vittoriosa se, Franco e Vitale non faranno in modo che ciò non avvenga. La Nuova Curinga, dopo il tonfo di Filogaso, affronterà una squadra, la Nuova Limbadi, della quale si sa poco, se non che si trova attualmente a pari punti della Nuova Curinga in classifica generale pur avendo disputato una partita in meno. Proprio perchè poco nota, bisogna affrontarla con cautela e, soprattutto con la dovuta concentrazione, quella che è mancata a Filogaso, onde evitare di fare ulteriori passi falsi. La partita clou della quarta giornata è, Nuova Filadelfia Ansel Acconia che, vista la vicinanza geografica delle due compagini, si può ritenere un derby. Entrambe provengono da due vittorie convincenti ma, quello che fa maggiormente piacere è che l’Ansel Acconia ha proposto fino ad ora un buon gioco ed una buona organizzazione di squadra, mentre la Nuova Filadelfia, a parte la falsa partenza, sta ora riprendendo i ritmi che la porteranno in alto, così come lo è sempre stata. Quanto detto è premonitore di una gara che si prospetta piacevole, combattuta e che, potrà essere risolta in qualsiasi momento perchè, le due squadre dispongono di eccellenti individualità nelle proprie formazioni. Per la Polisportiva Acconia che ospita l’Euro Girifalco, si presenta un ulteriore banco di prova visto che gli avversari sono di quelli duri, di quelli cioè che vanno affrontati con tutta la determinazione possibile per poterne avere ragione. Se, al fattore campo e alla organizzazione di gioco che, fino ad ora non è mai mancata, viene aggiunta un po’ di determinazione in più, allora la Polisportiva può finalmente conquistare l’intera posta in palio, aggiungendo punti in classifica generale che, fino ad ora, è l’unica cosa che è carente. Tra Nuova Valle e Badolato, sembra che non ci sono dubbi sulla vittoria degli ospiti, anche perchè le aspirazioni sono diverse e i risultati ottenuti fino ad ora lo sono altrettanto. Siamo convinto infatti che, sono proprio le motivazioni che fanno spesso il risultato sul campo e, quelle del Badolato, sono più concrete rispetto a quelle dei padroni di casa. Incontro duro tra duri, quello che si giocherà tra Petrizzi e Sporting Davoli; due squadre che non nascondono le loro ambizioni e che faranno di tutto per poterle sostenere impostando una partita che possa, alla fine, portare l’una o l’altra squadra alla vittoria. Il Petrizzi avrà sete di punti vista la sconfitta maturata a Bivongi (3-2), nel recupero infrasettimanale. Real Pianopoli e Filogaso sarà scontro alla pari perchè, al vantaggio del fattore campo, il Filogaso contrapporrà una squadra compatta così come ha dimostrato di esserlo contro la Nuova Curinga. Il Filogaso è, in ogni caso, una squadra che sa il fatto suo e che conosce i suoi limiti e le sue possibilità. Chiudiamo con il San Calogero dicendo che è arrivato il momento di mettere fieno in cascina, di rimpinguare cioè la sua classifica che, attualmente piange. Tre sconfitte consecutive, non sono cosa normale per cui, vista la inconsistenza dimostrata dalla squadra che andrà ad affrontare (Uesse Catanzaro), potrà essere l’occasione buona per dare una svolta al suo campionato, attualmente anonimo. Er. Ga.
NUOVA CURINGA: 1 – 2 NUOVA CALCIO LIMBADI
NUOVA CURINGA: Sorrentino, CamilLò, Pettinato, Martinez, Cerra, Colacchio, Nosdeo (23′ st La Fortuna), Tuoto, Zerbonia (15′ st Fragalà), Marturano (15′ st Grandinetti), Serratore.
In panchina: Grandinetti, Gigliotti, Scavello.
Allenatore: Spina
MARCATORI: 20′ pt Desiderato (L), 13′ st Corsaro (L), 30′ st Fragalà
NUOVA CALCIO LIMBADI: Graci, Ascone A., Maccarone (27′ st Contartese), Pontoriero A. (23′ st Pellicari), Corsaro, Po, Memori, Ventrici, Corsi (23′ st Cuiuli), Miserino, Desiderato.
In panchina: Limardo, Redi, Caparra, Spataro.
Allenatore: Di Mundo – Tripaldi
ARBITRO: Rispoli di Locri
Il Limbadi resiste agli assalti del Curinga
CURINGA – 11-10-2009 – Il Limbadi fa sua una partita spettacolare e combattuta. Ospiti in vantaggio al 20′ con Desiderato (il migliore dei suoi) sfuggito al fuorigioco del Curinga. Prima del raddoppio Desiderato colpisce il palo interno e la traversa; al 13′ st Corsaro su calcio d’angolo insacca sul secondo palo. Fragalà al 30′ st dimezza lo svantaggio. A cinque minuti dalla fine l’arbitro concede al Curinga un calcio di rigore contestato dagli ospiti: Fragalà segna, ma l’arbitro fa ripetere per invasione in area; al secondo tentativo Graci para. Dopo poco rigore su Desiderato: Cuiuli manda sul palo. Al sesto di recupero punizione a due in area per il Curinga, ma la traversa dice no all’ultimo attacco locale.
Il Quotidiano
Nuova Filadelfia 1 – 1 Ansel Acconia
Nuova Filadelfia: Michienzi, Vaccaro, Caruso G., Romagnuolo, Raffo, Simonetti, Grandi, Montauro, Caruso A.(Ruscio), Di Siena, Dastoli.
In Panchiana: Butruce, Mazzotta, Calafati, Servello, Buccimmà, Sisca.
Allenatore: Alessandro
ARBITRO: Lafandi da Locri.
Ansel Acconia: Matarazzo, Muraca S., Colloca, Michienzi (Di Cello S.), Morelli, Frijia, Perugino, Perri G., Vasta (Orlando), Arcuri, Di Cello L.,
In Panchina: Buccafurni Mercuri G. ,,Muraca L., Mazzotta, Torcasio F.
Allenatore: Galeoto
Marcatori: 38′ p.t. Arcuri; 47′ s.t. Ruscio
Gara avara di emozioni Solo i gol la ravvivano
di TOMMASO MANCARI FILADELFIA – Folta cornice di pubblico ieri al comunale di Filadelfia per la partita tra la squadra di casa e l’Ansel. Match che delude le attese senza azioni da rilevare,fino al 35′ quando Arcuri lascia partire una conclusione dal limite che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Al 40′ è ancora la squadra ospite a farsi viva con Ferri che si fa neutralizzare da Michienzi un colpo di testa molto pericoloso. Secondo tempo ancora più brutto e avaro di emozioni fino al 45′ s.t. quando Sisca pennella una punizione sulla testa del nuovo entrato Ruscio che sigla il pareggio.
Il Quotidiano
Grande Arcuri ma, alla fine è parità tra
Nuova Filadelfia e Ansel Acconia.
Filadelfia 11-10-2009– Un grande Arcuri, un suo Eurogol ma, alla fine, finisce in parità la partita tra Nuova Filadelfia ed Ansel Acconia. Una partita giocata all’insegna della qualità di gioco, divertente, avvincente con momenti di gioco esaltante. Lo ha fatto l’Ansel Acconia e, in misura minore, lo ha fatto anche la Nuova Filadelfia che ha avuto in Romagnuolo, il suo uomo migliore. Squadre inizialmente contratte, preposte allo studio dell’una sull’altra; attente in difesa, veloci in attacco ma, poche conclusioni verso rete. Mister Alessandro, squalificato, mette in campo, attraverso il suo secondo, uno schieramento prudente, perchè consapevole che Sisca, Ruscio e Buccinnà, non sono ancora al meglio delle loro condizioni fisiche. Neanche Caruso è quello dello scorso anno e, durante la partita, si è notato. Mister Calioto schiera invece un attacco vivace, con Di Cello e Vasta abili nello sfruttare la loro velocità, lasciando in panchina, per postumi di un infortunio, Orlando. La scelta si rivela azzeccata perchè la difesa locale è costantemente impegnata a frenare le folate offensive ora di Di Cello, ora di Vasta. In questa fase, l’elemento migliore è comunque Michienzi che, giganteggia davanti alla difesa, facendo sue tutte le palle alte e frenando sul nascere tutte le azioni avversarie. Arcuri è il solito attaccante aggiunto dai cui piedi, partono tutte le azioni più pericolose ed è lui stesso a rendersi pericoloso in più di una occasione. Concretizza la sua superba prestazione con un eurogol segnato, tra le altre cose, col sinistro che, non è il suo piede preferito. Il vantaggio è meritato perchè è l’Ansel Acconia la squadra che detta i tempi di gioco e che comanda lo stesso in qualsiasi zona del campo. Il secondo tempo non cambia fisionomia, con l’Ansel sempre in cattedra e con i locali protesi nella ricerca del pari. Sfiora la rete Orlando, subentrato a Vasta, sbaglia Perugino, mandando a lato, sbaglia Arcuri tirando debolmente tra le braccia di Michienzi. I pericoli, per l’Ansel, arrivano solo da tiri piazzati nei quali, Matarazzo, fa buona guardia la prima e, la seconda volta ma, alla terza, in pieno recupero, con una difesa schierata in linea e aperta alle incursioni avversarie, subisce la rete, di testa, di Ruscio, che regala alla sua squadra un punto insperato. Rammarico per i giocatori dell’Ansel e per l’allenatore che, forse, ha commesso l’errore chiave della partita, nella sostituzione di Michienzi che, fino a quel momento giganteggiava nella sua posizione di interditore. Peccato, perchè poteva essere una meritata vittoria mentre invece è stato solo un amaro pareggio.
Er. Ga.
NUOVA POL. ACCONTA 3 – 2 EURO GIRIFALCO
NUOVA POL. ACCONTA: Oscuro, Serratore, Mastroianni, Muraca D., Pingitore, De Pace, Muraca V., Nosdeo, De Sensi (36′ st Trovato), Dell’Aquila (23′ st Chiodo), Landolfi.
In panchina: Guzzi, Catanzaro, Panzarella, Trovato, Condoleo, Chiodo, Meli.
Allenatore: Fioretti
EURO GIRIFALCO: Stranieri, Curto (27′ st Scarpino), Ferraina, Bellini, Palaia, Signorello, Verre, Marino (20′ st De Filippo), Cuomo, Mellace, Marinaro (27′ st Strumbo).
In panchina: D’Auria, Strumbo, De Filippo, Giampà, Caruso, Catalano, Scarpino.
Allenatore: Cristofaro
ARBITRO: Sciammarella di Paola
MARCATORI: 40′ pi, 8′ st e 29′ st Muraca D. (NPA), 1′ st Cuomo (EG), 35′ st Scarpino (EG)
NOTE: espulso per doppia ammonizione Pingitore
Muraca devastante Girifalco, stop ad Acconia
ACCONIA – 11-10-2009 – Partita vibrante e densa di emozioni. In avvio Dell’Aquila in sospetta posizione di fuorigioco coglie il palo con un pallonetto. Al 38′ Palaia prende la palla e lancia Marinaro che sfiora il palo. Al 40′ punizione dal vertice dell’area, segna Muraca con tocco della barriera. Al 44′ Mellace sfiora il palo. Al l’st Cuomo pareggia dopo una mischia. L. vantaggio dei locali: al 8′ st punizione dal vertice dell’area: tira Dell’Aquila, il solissimo Muraca segna di piatto. Al 29′ st Muraca sfrutta una indecisione della difesa. Di Scarpino il gol del 3-2.
Il Quotidiano
SERRESE 1 – 1 N. CURINGA
SERRESE: Franzé I 6, Lo Bianco 6,5 (23′ st Rullo), Zaffino (21′ pt Valente 6), Fortebuono 6,5, Lattari 6,5, Scidà 6, Greco 6,5, Pisani M. 6,5 (29′ st Auteri), Russo 6,5, Franzé II6, Zaffino 6.
In panchina: Carioti, Pisani G, Ghiera, Randò.
Allenatore: Stumpo.
ARBITRO: Vallese di Paola.
N. CURINGA: Grandinetti F. 5, Currado 6, Paonessa 6, Schiavello 6,5, Riga 6 (7′ st Martinez
6) Colacchio 5,5 (29′ st Tovato s.v.), Gigliotti 6,5, Grandinetti G, 6, Tuoto 5,5, Zerbonia 6 (1′ st
Nosdeo 6) 6,5, Serratore 5,5.
In panchina: Sorrentino, Pettinato, Marturano, Spina.
Allenatore: Spina.
MARCATORI: 7′ pt Russo (S), 23′ pt Gigliotti (NC).
Coppa Calabria;
I ragazzi di Stumpo restano in dieci nei minuti finali per l’infortunio di Valente
Russo non basta alla Serrese
I locali falliscono il raddoppio e vengono raggiunti dalla rete di Gigliotti
di MIRKO TASSONE SERRA SAN BRUNO – Sotto una pioggia battente, per il secondo turno di coppa Calabria, la Serrese non va oltre il pari con il Nuova Curinga degli ex Zerbonia e Marturano. Parte bene la squadra di casa che dopo appena sette minuti passa in vantaggio con Russo, complice una macroscopica incertezza di Colacchio e Grandinetti. Tre minuti dopo i bianco blu ancora protagonisti. Dalla corsia destra parte uno spiovente per Pisani che, a colpo sicuro, batte a rete, ma sulla traiettoria s’inserisce il compagno di squadra Zaffino che salva il Curinga dal doppio svantaggio. Al 23′ però arriva il gran goal di Gigliotti che, dal vertice destro dell’area di rigore, scaglia una rasoiata e sorprende il non esente da colpe Franzé. Con il match nuovamente in equilibrio le due formazioni danno luogo ad un avvincente sfida nella zona mediana del campo. Al 27′ la Serrese ci prova dalla distanza con un tiro di Fortebuono, ma la palla termina sul fondo. Con il passare dei minuti la pioggia aumenta d’intensità e condiziona notevolmente la prestazione dei fantasisti. Ad inizio ripresa Spina lascia in panchina Zerbonia ed al suo posto manda in campo Martinez. Al 20′ della ripresa è proprio il nuovo entrato a mettere paura con una conclusione sulla quale provvidenzialmente rinviene sulla linea di porta Lattali. Con il trascorrere dei minuti il terreno di gioco diventa sempre più impraticabile. La Serrese non fa mistero di voler far proprio l’incontro e si spinge ripetutamente in avanti alla ricerca del successo. Sulle scorribande di Russo e Franzé fa però buona guardia la retroguardia giallo verde. Al 76′ sugli sviluppi di un tiro d’angolo, in piena area di rigore, Greco riesce a calciare ma la palla termina di poco oltre la traversa. Ultimi minuti in dieci uomini per la Serrese che, all’80’, perde Valente, vittima di uno scontro di gioco con un compagno di squadra, In attesa del triplice fischio entrambe le formazioni si attestano nella loro trequarti campo limitandosi a lanciare senza alcuna pretesa la palla in avanti.
Il ritorno il 4-11-2009 alle ore 14,30 al “Carlo Piro” di Curinga.
Il Quotidiano della Calabria
palle Ferme
Inarrestabile il Limbadi, unica squadra a punteggio pieno.
Tra pareggi sofferti e sconfitte inaspettate,
sono state fermate tutte le squadre favorite del Campionato.
Curinga 13-10-2009 E siamo solo alla quarta giornata di Campionato. Deludente ma, sfortunata la Nuova Curinga che, rimedia la seconda sconfitta consecutiva ad opera della Nuova Limbadi che è l’unica squadra a ritrovarsi a punteggio pieno e, imbattuta. In questi casi, non basta fare appello alla sfortuna e recriminare sulle occasioni mancate perchè, la squadra è stata costruita per vincere ma non riesce ancora a mantenere le promesse di vittoria. E’ chiaro che, quando c’è una sconfitta di mezzo, i demeriti non sono solo della squadra perdente ma, bisogna mettere in conto anche i meriti degli avversari, in questo caso quelli del Limbadi che, non a caso, è l’unica squadra a punteggio pieno. Ospiti in vantaggio per ben due volte, che rischiano di essere raggiunti se l’arbitro, Sig. Rispoli di Locri, non avesse fatto ripetere un rigore, inizialmente trasformato e successivamente sbagliato ma che, alla fine, avendo sbagliato anche loro il loro rigore, hanno legittimato il giusto risultato finale. Perde anche l’Euro Girifalco o, se vogliamo, vince meritatamente la Polisportiva Acconia che trova in Muraca D. il goleador della giornata. Partita ricca di gol, ben cinque, con la Polisportiva Acconia che passa per prima in vantaggio, che si fa poi raggiungere e che dilaga nel secondo tempo portandosi sul 3-1 per poi finire con una vittoria per 3-2. Cade lo Sporting Davoli contro il Petrizzi di Valente. Una partita che si sblocca solo in pieno recupero, al 47′ del secondo tempo, quando Valente, si ricorda di essere ancora uno spietato risolutore. Rammarico per la Serrese che viene bloccata sul 2-2 dal Bivongi, subito, per giunta, su rigore. Non gli sono bastati alla Serrese le reti di Russo e Chiera per avere la meglio sul Bivongi perchè, un grande Riggio la mette al tappeto con una splendida doppietta da manuale. Anche il Badolato recrimina perchè bloccata dall’ultima della classe, Nuova Valle, che riesce a rimontare un 1-3 e con la terza rete segnata al 46′ del secondo tempo. Un Badolato che è praticamente crollato nel secondo tempo, quando cioè pensava di avere ormai assolto al suo compito ma che ha mollato le redini ritrovandosi alla fine con il risultato di parità che, per i locali costituisce il primo punto conquistato sul campo. Non era certo stato preventivato alla vigilia un risultato del genere ma, bisogna pensare che c’è sempre l’avversario in campo e questo, può avere sempre una risorsa nascosta che può metterti in difficoltà. In parità è finita la partita tra Nuova Filadelfia e Ansel Acconia con gli ospiti a controllare fin dall’inizio della partita il gioco in campo, passando per primi in vantaggio con un gran gol di Arcuri ma che, alla fine, in pieno recupero, si lascia raggiungere con una rete che forse, era possibile anche evitare. Rabbia, rammarico ma, in conclusione, anche soddisfazione perchè consapevoli di avere ottenuto un risultato positivo dove, pochi riusciranno a fare di meglio. Primi tre punti per il San Calogero che si è trovato sotto di una rete nel primo tempo ma che nel secondo, con un grande forcing, è riuscito a raggiungere la meritata vittoria. Piccoli passi per il Real Pianopoli che non va oltre il pari contro il Filogaso nella partita anticipata la sabato. Deve comunque recitare il “mea culpa” perchè, oltre ad essere andato in vantaggio per primo, ha pure colpito due legni e, alla fine ha sbagliato anche un rigore che avrebbe potuto metterlo al riparo definitivamente. La giornata è stata ricca di gol, ben 26; rimangono solo due la squadre imbattute (Serrese e Nuova Limbadi) , una sola a punteggio pieno (Limbadi), anche se con una partita in meno, e, infine, primi punti per San Calogero e Nuova Valle.
Er. Ga.
Palla al Centro, si ricomincia.
Sulle macerie spesso, si costruisce meglio e, in modo più duraturo.
Curinga 16-10-2009 Domenica si giocherà la quinta di campionato e, ci sarà lo scontro al vertice tra Serrese e Nuova Limbadi che stabilirà chi, tra le due, dovrà essere la leader del girone visto che lo stesso, stenta ancora a decollare. In ritardo di preparazione e di punti la Nuova Curinga, il Badolato e, la Nuova Filadelfia squadre che, per qualità ed aspirazioni, sono una spanna al di sopra di tutte le altre. Tutte e tre le squadre citate, chi per un motivo, chi per un altro, si trovano purtroppo in ritardo: Il Badolato si starà ancora “mangiando le mani” per i due punti persi a Vallefiorita, per una rete subita al 46′ del s. t., in modo rocambolesco, che la ha costretta al pari contro la Nuova Valle; altrettanto si può dire per la Nuova Curinga, alla quale, non è bastata una superba partita per avere la meglio sulla Nuova Limbadi che, al contrario, ne è uscita vincitrice. Un rigore fallito ed altre azioni da rete mancate, la hanno condotta alla seconda sconfitta consecutiva per la quale, molti tifosi locali hanno contestato esplicitamente sia la società che i giocatori in campo. Infine, la Nuova Filadelfia che, più che sul mancato risultato di domenica scorsa contro l’Ansel Acconia e che, non avrebbe nemmeno meritato, deve recriminare sulla scarsa condizione in cui si trova il suo goleador Caruso, che stenta ancora a trovare la via della rete. Sono squadre che sapranno comunque risorgere, e che sapranno trovare nel più breve tempo possibile la via della vittoria che le riporteranno nei piani alti della classifica generale. La Nuova Curinga, sa già come risorgere dalle macerie perchè, come esperienza vissuta, sa quali sono i modi per risollevarsi. Lo ha fatto l’anno scorso quando, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha poi conquistato la qualificazione ai Play-off. Sulle macerie infatti, si costruisce meglio e in modo più duraturo e, con più oculatezza, si può migliorare anche la qualità e la determinazione utili per raggiungere l’obiettivo finale. La prossima partita di Pianopoli, anticipata al sabato, potrà essere il trampolino di lancio dal quale, avvertire tutte le altre concorrenti che, la Nuova Curinga c’è e che ci vuole essere fino in fondo. Il Badolato, affrontando la Nuova Polisportiva Acconia, deve ancora una volta stare attento per evitare di fare la stessa fine fatta contro la Nuova Filadelfia. Affronta infatti, una squadra attualmente in forma e che, finalmente è riuscita ad abbinare il bel gioco ai risultati. Lo ha dimostrato a Davoli, pareggiando la partita, lo ha dimostrato contro l’Euro Girifalco mettendolo al tappeto. Per la Nuova Filadelfia, che sta finalmente ritrovando la condizione, non dovrebbe essere difficile conquistare i tre punti contro la Uesse Catanzaro che, fino ad ora, non ha dimostrato grandi qualità. Una buona occasione si presenta per l’Anse Acconia che, affrontando la Nuova Valle, ha possibilità, con una vittoria, di stabilizzarsi nei piani alti della classifica generale. Lo meriterebbe, se non altro per il bel gioco che, domenica dopo domenica sta proponendo ai suoi tifosi e a tutti gli spettatori che la hanno vista protagonista. Euro Girifalco – Petrizzi, sarà un banco di prova per entrambe le squadre in quanto vorranno dimostrare l’una all’altra di volere dire la propria in questo campionato. L’Euro Girifalco deve subito “dimenticare” la sconfitta di Acconia e, per farlo deve puntare dritto alla vittoria; il Petrizzi deve invece “ricordare” ciò che di buono ha fatto contro il Davoli e sperare che Valenti, si svegli definitivamente per dare una scossa alla sua squadra e condurla alla vittoria. La Partita Sporting Davoli – Bivongi, anticipata al sabato, potrebbe nascondere qualche sorpresa, così come a sorpresa, potrebbe essere il risultato tra Filogaso e San Calogero. Le squadre di casa sono favorite ma, le buone prestazioni delle ultime partite, depongono anche qualche residua speranza per le squadre ospiti.
Al campo il responso finale.
Er. Ga.
R. PIANOPOLI 3 – 0 N. CURINGA
REAL PIANOPOLI: Mascaro A., Mazzei A., Albace, Talarico (36′ st Mazzei Antonello), Scerbo, Sereno, Notaro, Fazio (38′ st Aiello), Gaetano, Isabella (20′ st Guzzo), Marotta.
In panchina: Grandinetti, Palmieri, Sgarrella, Roberti.
Allenatore: Marotta
Arbitro: Barca di Taurianova.
NUOVA CURINGA: Sorrentino, Currado, Pettinato, Schiavello (21′ st Martinez), Riga, Camillò
(38′ pt Gigliotti), Zerbonia, Tuoto, Fragalà (15′ s.t. Grandinetti) Marturano, Serratore.
In panchina:Grandinetti F., Nosdeo, La Fortuna, Paonessa.
Allenatore: Spina
MARCATORI: 10′ st Notaro, 15′ e 18′ st Gaetano
A Pianopoli il Real domina la N. Curinga
PIANOPOLI 18-10-2009- Partita sciènza storia quella tra il Real Pianopoli e la Nuova Curinga. Un tre a zero che non ammette repliche, con l’aggiunta di due legni a favore dei padroni di casa, uno colpito al 7′ con Scerbo e l’altro con lo stesso Scerbo al 25′. I padroni di casa passano in vantaggio al 10′ con Notaro che finalizza al termine di una mischia in area avversaria. Il raddoppio arriva poco dopo con Gaetano, lesto ad approfittare, con un pallonetto dal limite, di una disattenzione di Tuoto. Lo stesso Gaetano al 18′ sigla il definitivo 3-0 che condanna un’abulica Nuova Curinga.
Il Quotidiano della Calabria
Ansel Acconia 2 1 Nuova Valle
Ansel Acconia: Buccafurni, Muraca S., Colloca, Michienzi, Di Cello S., Muraca L., Perri G., Morelli, Vasta, Arcuri, Di Cello L.,
In Panchina: Lepore, Frijia, Perugino, Torcasio F., Matarazzo, Molinaro G.
Allenatore: Galeoto
Marcatori: 18′ p.t. Morello. 21′ s.t. Arcuri; 45′ s.t. Gagliardo
Nuova Valle: Sparacino A., Sparacino D., Merenda, Muzzi, Sestito, Chiarella, Vitaliano, Paone, Riga, Barbieri, Merlino
In Panchina: Lanzellotti, Grande, Marcella, Facciolo, Gagliardo, Sanso, Misdea.
Allenatore: Capalano
Arbitro: Fuoco da Crotone.
NOTE: Ammoniti Frija(AA)e Riga (NT). Angoli 6 a 2 per l’Ansel Acconia
Ansel sempre più in alto Paone all’ultimo assalto
ACCONIA Di CURINGA 18-10-2009 -I padroni di casa conquistano una vittoria importante per mantenere la zona alta della classifica. Le due matricole hanno disputato una bella gara. Al 18′ i locali si portano in vantaggio. Punizione di Perri che termina contro la barriera. Palla che finisce a Morelli che, con un bel tiro da fuori area, batte il portiere di Vallefiorita. Nella ripresa l’Ansel si porta sul doppio vantaggio grazie al rigore trasformato da Arcuri. Penalty concesso dal direttore di gara per atterramento di Frijia. La rete della compagine del presidente Muccari arriva nel recupero. Paone si presenta solo davanti a Beccafurni e con un pallonetto, mette in rete.
b.s.
L’Ansel Acconia vince ma, non stravince.
Acconia 18-10-2009
Ciò che sulla carta sembra facile, a volte diventa più difficile da superare ma, non impossibile. Anche oggi l’Ansel poteva segnare almeno cinque reti, si è invece limitata a segnarne solo due, sufficienti però per superare una squadra che è sembrata tutt’altra cosa di ciò che la sua classifica, deficitaria di punti, potesse far credere. Una partita combattuta tra due squadre organizzate meglio in difesa che non in attacco. Una linea difensiva degli ospiti che non si è scomposta dall’inizio alla fine così come quella dell’Ansel che ha visto un buon Di Cello S. supportato da due buoni interditori come Michienzi e Morello. Anche la Nuova Valle ha manifestato delle buone individualità difensive in Muzzì e Chiarella ed anche, un buon Riga in avanti che però, ha spesso preferito giocare da solo. Il migliore in campo è stato comunque Di Cello L. , per acume tattico e perchè ha aiutato il reparto di centrocampo, impostando, concludendo tenendo palla per fare salire sistematicamente la sua squadra. Per Antonio Arcuri, ormai non ci sono più aggettivi per poterlo qualificare perchè, le sue prestazioni sono sempre valide e significative; ha, anche oggi, lasciato la sua impronta sulla partita, con una rete segnata su rigore che, lui stesso si era procurato. Andando con ordine, si è giocato un primo tempo all’insegna della velocità, con i giocatori ospiti che, tentavano l’anticipo su ogni pallone giocato, perchè consapevoli che gli avversari di oggi, non potevano essere affrontati sulla tecnica perchè, su questa, insuperabili. In ogni caso, le occasioni da rete per i locali, si sono presentate fin dall’inizio quando Di Cello e Vasta hanno sprecato favorevolissime occasioni. poi, una traversa colpita su una incursione in area da Di Cello ed una rete segnata da trenta metri da Morello che lascia di stucco il portiere su un bolide di inaudita potenza. L’uno a zero non trasforma la fisionomia della partita perchè gli ospiti combattono a fronte alta e, i locali, giocano la loro partita senza mettere in atto tatticismi particolari. Ottima occasione per Vasta che è in questa occasione molto sfortunato per avere trovato il portiere Sparacino pronto a respingere di istinto il primo suo tiro, e di riflesso il secondo che , per tempestività e per precisione sembrava dovesse finire in rete. Sparacino quindi, tiene in partita la sua squadra, limitando i danni e incitando ad una maggiore concretezza i suoi compagni di squadra. Il secondo tempo si gioca inizialmente sotto un buon acquazzone ma, le condizioni atmosferiche non alterano le intenzioni di vittoria da parte di entrambe le squadre. Più intraprendenti gli ospiti ma, Buccafurni, non ha mai rischiato di capitolare. Si distende bene su un insidioso rasoterra neutralizzandolo, e altrettanto bene si comporta su uno spiovente che arriva in area dalla tre quarti. Nel miglior momento degli ospiti, arriva la seconda rete per l’Ansel su rigore, trasformato da Arcuri che, in una concitata azione, viene messo giù senza tanti complimenti dal suo avversario di turno. Il due a zero, tranquillizza la squadra che, gestisce il vantaggio senza mai rischiare. Si continua a sbagliare sotto rete e, alla fine, arriva quella rete che non ti aspetti. Lancio a scavalcare la difesa, Gagliardo brucia sullo scatto Di Cello e, con un delizioso pallonetto, scavalca l’incolpevole Buccaforni in uscita. E’ troppo tardi per temere il peggio e per dare speranza agli ospiti per una possibile rimonta perchè è il 46′ del secondo tempo. Per ora, l’Ansel accumula punti e si pone in alto in classifica, andando avanti si vedrà Er. Ga.
BADOLATO 2 – 2 POL. ACCONIA
BADOLATO: Menniti, Lucifero, Piccoli, Centola ( 9’st Fraietta), Dardano, Vetrario (43’pt Lepanto), lozzo, Mastria, Minisi(16’st Martello), Chiodo, Loccisano.
Allenatore: Stanizzi N.
NOTE: ammoniti Lucifero, Loccisano, Minisi, Vetrano, Chiodo(B). Condoleo, Monaco, Landolfi, De Pace (A).
ACCONIA: Oscuro, Serratore, Nastroianni, Muraca, Trovato R., De Pace, Panzarella, Landolfi( 35’st Nosdeo), Neri ( 1′ st Gareri), Dell’ Acqua (44’st Trovato V.) Condoleo.
Allenatore: Fioretti
ARBITRO: Basile (Crotone)
MARCATORI: 33′ Mastria(B) – 52′ Dell’ Acqua (A) – 60’Loccisano(B) – 83′ De Pace (A)
Delusione a fine gara tra i dirigenti e i tanti tifosi accorsi sugli spalti
Il Badolato paga i soliti errori
La N. Acconia fa la sua onesta partita e porta via un punto importante
di FRANCO LAGANÀ
BADOLATO 18-10-2009- Amarezza, delusione, tanta rabbia, sono stati questi i sentimenti espressi nelle dichiarazioni del dopo partita da Mister Stanizzi, per due punti persi per i continui malintesi della difesa, che penalizzano la squadra. “Prenderò alcuni provvedimenti disciplinari verso chi con il suo comportamento ha penalizzato la squadra. Mi dispiace per i nostri tifosi, e per la società. In settimana analizzeremo questa partita pareggiata dagli ospiti per colpa dell’assetto difensivo, che continua a sbagliare nel finale della gara. E’ successo a Filadelfia, e l’errore si è ripetuto oggi”. Soddisfazione negli spogliatoi ospiti nelle dichiarazioni di Mister Fioretti, “Un pari meritato, che ci consente di guardare al prosieguo del campionato con più serenità, considerando che in questo inizio di campionato abbiamo affrontato le squadre candidate alla promozione”. Parte bene il Badolato, che costringe gli ospiti a chiudersi nella propria meta campo. Loccisano, Centola e Piccolo, mettono in difficoltà il portiere Oscuro. Al 26′ si grida al gol su tiro di Vetrano, ma il pallone sfiora il palo. L’Acconia si limita a giocare in contropiede. Il gol arriva al 33′, cros di Minisi e Mastria da fuori area insacca. Sterile la reazione degli ospiti, ben controllati da lozzo e compagni. Per sostituire Vetrano, reo di un fallaccio ai danni di un avversario, saltano gli schemi di Stanizzi, e si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa, in campo scende un’Acconia decisa e determinata a raggiungere il pari, il Badolato soffre, e la difesa capitola al 7′ con il gol realizzato da oltre 20 metri da Dell’Acqua, che sorprende il portiere Menniti. La rete scuote i giocatori del presidente Larocca, che vanno in vantaggio con Loccisano, che sfrutta un ottimo passaggio di Fraietta, il migliore in campo nella ripresa. A questo punto gli ospiti non hanno nulla da perdere e si proiettano in avanti con azioni pericolose, ma l’attento Menniti nega la gioia del gol. Il Badolato ha due palle gol per chiudere la partita con incursioni di Fraietta, Chiodo e Martello, che sono sfortunati sotto rete. Ma nel finale la difesa giallorossa commette una serie di errori, che permettono agli ospiti di pareggiare su un’azione d’angolo.
Il Quotidiano della Calabria.
A palle Ferme
All’insegna del “tre”
Curinga 21-10-2009 Tre, le partite rinviate al Petrizzi; Tre le squadre in ritardo in Classifica Generale (Badolato, Nuova Curinga, Nuova Filadelfia); Tre, le reti subite dalla Nuova Curinga a Pianopoli; Tre le reti subite dalla stessa squadra a Filogaso; Tre, le sconfitte consecutive racimolate dalla Nuova Curinga. Questi i dati essenziali dedotti dalle prime cinque giornate di campionato di Prima Categoria girone C. Il Badolato che non riesce più a vincere, così come la Nuova Filadelfia che detiene l’attuale record delle partite pareggiate e, infine, la Nuova Curinga che ha smarrito la via della vittoria e detiene il record attuale delle sconfitte consecutive. In testa alla classifica generale, un inedito quartetto con ben due matricole di categoria ( Sporting Davoli e Ansel Acconia). Lo Sporting Davoli, avanza a suon di gol (ben 16 in cinque partite) e, l’Ansel Acconia che fa lo stesso proponendosi con ottime prestazioni. Per Serrese e Limbadi, che devono recuperare lo scontro diretto, potrebbe essere la “testa”, in caso di vittoria dell’una sull’altra squadra. Non riesce a vincere la Nuova Filadelfia a Catanzaro anzi, rischia di perdere la partita perchè riesce a recuperarla solo al 47′ del secondo tempo quando si aspetta solo il fischio finale da parte del direttore di gara. E’ sicuramente crisi per la Nuova Filadelfia, non solo di risultati ma anche e soprattutto di prestazioni che, non non sono più quelle della stagione sportiva 2008-2009. La squadra sorpresa è, per il momento, il Filogaso che, dopo avere battuto la Nuova Curinga, si è ripetuto contro il San Calogero, raggiungendo quota 10 punti insediandosi in testa alla classifica generale. Ottimo pari della Polisportiva Acconia a Badolato dove, per due volte sotto nel risultato riesce a rimontare in entrambi i casi portando a casa un punto meritatissimo. Delusi i tifosi locali ma, soddisfatti i ragazzi di mister Fioretti perchè consapevoli di avere compiuto una splendida impresa. In questa giornata, non si sono potute disputare ben due partite per impraticabilità : Serrese – Limbadi ed Euro Girifalco – Petrizzi. Per quest’ultima, è già la terza volta che non ha potuto disputare la sua partita per le condizioni atmosferiche che hanno reso i terreni di gioco impraticabili. La classifica è ancora corta e, fino ad ora pone: Lo Sporting Davoli in testa alla classifica sia per punti guadagnati che per reti segnate; La Nuova Valle che, nonostante le sconfitte subite, riesce a proporsi con buone prestazioni; La Nuova Filadelfia che non riesce ad essere la squadra del 2008-2009; La Nuova Curinga che ha smarrito la via della rete nonostante avesse in squadra il fior fiore degli attaccanti di categoria; Il San Calogero che continua a perdere anche quando non dovrebbe; La Polisportiva Acconia che sta attraversando un ottimo stato di forma dimostrandolo affrontando squadre di valore come: Limbadi, Serrese, Badolato, Euro Girifalco; L’Ansel Acconia che è ancora costretta a creare dieci azioni da rete per poterne segnare una in più dell’avversario e vincere le sue partite; Il Badolato, che sta deludendo oltre misura tutti i suoi sostenitori; La Serrese e la Nuova Limbadi , che si sono proposte, fino ad ora, come le squadre più concrete del campionato; Il Real Pianopoli che, punto dopo punto si è insediata alle spalle della testa della classifica; L’Euro Girifalco che, stenta a trovare continuità di gioco e di risultati; Infine, la Uesse Catanzaro che, ci hanno fatto credere di essere una delle squadre favorite del campionato e che invece ha offerto fino ad ora prestazioni da “scapoli e ammogliati”.
Er. Ga.
Palla al Centro, si ricomincia.
Un Derby che ha tutto il sapore della rivincita.
Curinga 22-10-2009 Le novità della settimana sono essenzialmente due: La prima, è che il Petrizzi nella gara di recupero infrasettimanale, ha regolato la forte Nuova Limbadi con una rete segnata al 51’ minuto del secondo tempo; La seconda, è che la Nuova Curinga, anticipa a Sabato la sua gara contro la Serrese e, per giunta, giocherà allo stadio di Filadelfia. La particolarità di questa giornata è che tutte le squadre di “Nuova” generazione, giocheranno tutte in casa. La Nuova Limbadi ospiterà lo Sporting Davoli;
a Nuova Filadelfia ospiterà il Filogaso;
La Nuova Valle la Uesse Catanzaro;
La Nuova Curinga, come detto, ospiterà la Serrese;
Infine, la Nuova Polisportiva Acconia, ospiterà l’Ansel Acconia in un derby che ha tutto il sapore della rivincita. Sarà questa una partita dallo spettacolo assicurato perché si affrontano in un momento di forma smagliante per entrambe . La Polisportiva, ci ha ormai abituati a prestazioni di prestigio, merito anche del suo Allenatore Mister Fioretti; Anche l’Ansel Acconia non è da meno perchè si sta ormai consacrando come squadra rivelazione del campionato. Un secondo derby si giocherà a Petrizzi tra la squadra di casa e il blasonato Badolato. I locali, galvanizzati dalla vittoria infrasettimanale ottenuta contro una forte Nuova Limbadi, punteranno alla vittoria consapevoli sia della loro forza che dal momento poco felice che sta attraversano il Badolato che, purtroppo, non riesce più a vincere. Non sono solo i due derby a catturare l’attenzione dei tifosi perché, domenica, si giocheranno partite di notevole importanza per la evoluzione della classifica generale. Saranno in buona parte scontri di vertice o quasi, con la Nuova Limbadi che ospiterà lo Sporting Davoli mettendo a confronto il migliore attacco (Sporting Davoli 16 reti all’attivo) contro la migliore difesa (Nuova Limbadi con 2 reti al Passivo). Nuova Filadelfia – Filogaso sono entrambe assetate di punti e vorranno dimostrare ai propri tifosi che la posizione occupata dal Filogaso non è casuale ma frutto di sagacia tattica, e che, la carenza di punti in classifica generale è per il Filadelfia solo momentanea . Importanza fondamentale assume la partita tra Nuova Curinga e Serrese. I padroni di casa sono consapevoli che non si possono più permettere passi falsi perché, se dovesse succedere un’altra volta, si complicherebbe ulteriormente il progetto di risalita. Mister Spina, al quale trema ormai la terra sotto i piedi, dovrà inventarsi schemi e tattiche nuove se vuole avere la meglio sulla capolista Serrese. Bivongi – Euro Girifalco è una partita che potrà dire tante cose: primo fra tutte se i locali, sono sempre quella solita squadra dal rendimento altalenante e se, le sue sonore sconfitte sono solo causa di male di trasferta. Per l’Euro Girifalco, che ha ancora una partita da recuperare, potrà essere la partita che gli potrebbe far fare il definitivo salto di qualità. Partita da tripla è San Calogero – Real Pianopoli. Da una parte, perché i padroni di casa, pur non attraversando un momento di forma felice, possono sfruttare il fattore campo a loro favorevole. Dall’altra perché il Real Pianopoli si presenterà col morale alle stelle per avere ottenuto, domenica scorsa, una vittoria eclatante contro una squadra favorita di questo campionato. Scontro tra poveri quello che si disputerà tra Nuova Valle e Uesse Catanzaro perché sono le squadre che occupano attualmente le ultime due posizioni di classifica. Delle due squadre, la Nuova Valle, pur perdente, può almeno vantare delle ottime prestazioni mentre, la Uesse Catanzaro, non può vantare nemmeno queste.
Er. Ga.
N. CURINGA 3 – 1 SERRESE
N. CURINGA: Sorrentino, Currado, Pettinato, Tuoto, Cerra, Carnillò, Martinez, Marturano ( 22′ st. Schiavello), Zerbonia, Grandinetti G. (30’st Gigliotti), Serratore (40′ st Riga).
In panchina: GrandinettiF, Fragalà, Pavonessa, La Fortuna
Allenatore. Spina
MARCATORI: 7′ pt Grandinetti (N. e), 28′ pt e 38′ st Serratore (Ne), 43′ st Pisani (S)
SERRESE: Carioti, Caridà, Lo Bianco, Fortebuono, Lattari, Scidà, Greco, Pisani M., Ghiera, Franzé II, Zaffino L
In panchina: Zaffino B., Rullo, Pisani G., Inzillo
Allenatore. Stumpo
ARBITRO: Marafioti di Cosenza
NOTE: ammoniti: Greco (S)
Tris di reti per i padroni di casa. Non serve il gol degli ospiti al 43′ st
La N. Curinga espugna la Serrese
di MIRRO TASSONE
CURINGA – Nell’anticipo i locali hanno affondato la Serrese con un perentorio 3-1. Certo i ragazzi di Albano dalla loro hanno l’attenuante di aver disputato il match senza lo squalificato di lungo corso Stumpo, l’indisponibile Russo e l’infortunato Valente. Dopo appena 7′ la compagine di Spina passa in vantaggio con Grandinetti, veloce a sfruttare una clamorosa disattenzione della difesa bianco blu. 4′ dopo un rinvio corto di Carioti regala a Serratore la palla del doppio vantaggio. Nella ripresa i locali cercano di addormentare il match. Al 38′ le speranze della Serrese vengono definitivamente mortificate dalla doppietta di Serratore che manda fuori causa il non esente da colpe Carioti. A 2′ dal termine la compagine di Albano riesce ad accorciare le distanze con Pisani.
Il Quotidiano
Su un terreno di qualità, una squadra di qualità.
Lezione di Calcio dalla Nuova Curinga alla capolista Serrese.
Filadelfia 24-10-2009 Su un campo di qualità, una squadra di alta qualità. E’ la Nuova Curinga che fornisce una lezione di calcio alla capolista Serrese divertendo, oltre ogni aspettativa, i suoi tifosi. Troppa qualità in questa squadra per un campionato di Prima Categoria; un Tuoto monumentale un Grandinetti superbo, un Camillò fenomenale, un Marturano superlativo e così via dicendo per tutti i giocatori in campo. Il giocatore tatticamente indispensabile a questa squadra è Zerbonia che, assieme a Serratore costituiscono una coppia d’attacco perfetta. Il primo a creare spazi ed il secondo a svariare dietro la prima punta per inserirsi al posto giusto e, al momento giusto negli spazi e trasformare in rete tutto ciò che la sua squadra produce. Dalla prestazione di oggi si può anche capire perchè, questa squadra ha subito tre sconfitte consecutive ed è comprensibile se si pensa alla grinta e all’agonismo messi in campo da ogni squadra di questo campionato. Quando si incontrano squadre di alta qualità tecnica come quella della Nuova Curinga, gli avversari rimangono incantati e, altro non possono fare che, contrastarli sulla grinta e sull’agonismo che a questi giocatori , purtroppo mancano. La bella partita di oggi ha riconciliato i numerosi tifosi della Nuova Curinga presenti sugli spalti con la squadra, ed oggi, hanno avuto conferma che, su un terreno o, campo di patate, come quello di Curinga, questa squadra, non può esprimersi al meglio per cui, si trova inevitabilmente in evidente difficoltà. Ottime squadre quelle viste oggi in campo, con due schieramenti speculari e, con giocatori di ottima qualità da ambo le parti. Un 4-3-3 che ha catalizzato il gioco per lungo tempo a centrocampo. Alla Nuova Curinga sono però bastati solo sette minuti per passare in vantaggio ed altri venti per raddoppiare. Chiude infatti il primo tempo sul due a zero e ciò potrebbe rendere paga una qualsiasi squadra. Non la Nuova Curinga di oggi che, azione su azione, costruisce, diverte e sfiora la terza rete in più di una occasione, fermati solo dai legni della porta avversaria. Il portiere Sorrentino vive oggi una giornata tranquilla, anche perchè l’asse centrale Camillò Marturano Zerbonia funzione a meraviglia. Colpiscono ancora alla mezz’ora del secondo tempo con l’uomo inarrestabile, Serratore, che supera con un pregevole pallonetto il portiere ospite. Nonostante il passivo, la Serrese si muove bene, soprattutto con palla a terra e, con i suoi uomini migliori Fortebuono, Greco e Chiera. E’ proprio Greco che, al 42′ del secondo tempo, direttamente su punizione, segna la rete del definitivo 3-1, perforando la difesa con un fendente che si infila tra le gambe della barriera e si insacca in rete nonostante l’estremo tentativo di parata di Sorrentino. Concludiamo pronosticando la Nuova Curinga come squadra prossima al rientro nei ranghi che le competono; troppo forte per non essere così ma, dalla prossima, quale stadio ospiterà le sue partite? Constatato ormai che il “Carlo Piro” di Curinga è inadeguato a questa squadra, perchè non pensare ad una stabile disputa delle proprie partite a Filadelfia? In questo stadio infatti, la squadra ha dimostrato tutte le sue qualità. Può essere questo uno schiaffo morale alla amministrazione comunale che, tanto ha promesso durante la campagna elettorale e che tanto poco ha fatto per aiutare questa squadra e questi tifosi che, sicuramente, meritano ben altro. Se la “voglia di futuro è questa”, allora segniamocela al dito e ricordiamocene alle prossime elezioni.
Er. Ga.
N. P. ACCONIA 0 – 2 ANSEL A.
N. P. ACCONIA: Oscuro, Condoleo (24′ st Trovato V.), Serratore, Muraca D., Trovato R., De Pace, Panzarella, Landolfi, De Sensi, Dell’Aquila (8′ st Nosdeo), MuracaG.
In panchina: Guzzi, Catanzaro, Mastroianni, Neri, Chiodo.
Allenatore: Fioretti
Ammoniti: De Sensi, De Pace, Muraca D., Condoleo e Nosdeo (NA), Di Cello L., Orlando, Michienzi (A). Angoli 3-2 per l’Ansel.
ANSEL A.: Buccafurni, Colloca, Michienzi (31′ st Perri), Muraca S., Di Cello F., Vasta (38′ st Molinaro), Morelli, Orlando (43′ st Torcasio), Arcuri, Di Cello L.
In panchina: Matarazzo, Perugino, Lepore.
Allenatore: Galioto
ARBITRO: Fiorenza di Locri
MARCATORI: 14′ st Di Cello S., 22’Orlando.
NOTE: espulsi al 35′ st De Sensi e Fioretti.
L’Ansel vittoriosa con Di Cello e Orlando
ACCONIA 25-10-2009 – L’ Ansel si aggiudica il derby di Acconia. Nel primo tempo, due le azioni degne di nota. Al 13′ un tiro di Muraca diretto all’incrocio, vede il portiere Boccafurni, in una respinta spettacolare. Lo stesso estremo difensore si ripete, respingendo al 38′, un colpo di testa di De Sensi, su assist di Dell’Aquila. Pallone che finisce sui piedi di Panzarella che, costringe alla parata il portiere ospite. Nella ripresa le due reti. Di Cello S. raccoglie una punizione di Arcuri e di testa, batte Oscuro, il raddoppio di Orlando su cross di Di Cello L. Da segnalare l’infortunio a Vasta.
b.s.
Polisportiva Acconia 0 2 Ansel Acconia
Polisportiva Acconia: Oscuro, Condoleo, Serratore, Muraca, Trovato R., De Pace S., Panzarella, Landolfi, De Sensi, Dell’ Acquila, Muraca.
In Panchina: Guzzi, Catanzaro, Mastroianni, Nosdeo, Neri, Trovato V., Chiodo
Allenatore: Fioretti
Ansel Acconia: Buccafurni, Muraca S., Colloca, Michienzi, Di Cello S., Mercuri L., Morelli, Vasta, Orlando, Arcuri, Di Cello L.,
In Panchina: Matarazzo, Lepore, Perugino, Torcasio F., Molinaro G. Perri G.,
Allenatore: Galeoto
Marcatori: 15′ s. t. DiCello S. 25′ s.t. Orlando
ARBITRO: Fiorenza da Locri
La Polisportiva Acconia inciampa sull’Ansel Acconia.
Un arbitraggio disastroso che, condiziona la partita ma non il risultato.
Acconia 24-102009 E’ stata una bella partita quella giocata tra la Polisportiva Acconia e Ansel Acconia. Un Derby che ha avuto tutto il sapore della vendetta e che si è gioca in condizioni ideali di pubblico, di condizioni atmosferiche e, non per ultimo di condizioni fisiche ottimali per gli atleti delle due squadre. Una partita sentita dalle tifoserie locali e, la numerosa presenza sugli spalti ne è stata la conferma. Nessun timore per eventuali intemperanze esterne perchè, Acconia, con le sue tifoserie, ha già dimostrato grande civiltà, comportandosi come di dovere nonostante si trattasse di un Derby. Unica forza dell’ordine una sola guardia municipale alla quale, solo successivamente si sono associati i Carabinieri della locale stazione senza però che ce ne fosse bisogno. Le due squadre scendono in campo per affrontarsi a testa alta e, dispongono in campo tutte le carte preziose di cui dispongono: Arcuri , Orlando e Di Cello da una parte e, Muraca, dell’Aquila e De Sensi dall’altra. Schieramenti inizialmente prudenti con le due linee difensiva e di centrocampo molto vicine tra loro e che lottano con vigore a centrocampo. Partita maschia che i giocatori mettono in atto fin dall’inizio della gara; nessuno, nei contrasti, si tira indietro e, per questo, l’arbitro, interpretando come violenti i normali contrasti di gioco, fischia continuamente spezzettando sistematicamente lo stesso. Il primo quarto d’ora è dell’Ansel ma, nel successivo è la Polisportiva Acconia a farsi vedere dalle parti di Buccafurni. I pericoli, per l’intero primo tempo, arrivano solo da calci piazzati e, la paura di perdere, lascia le due squadre più a contenere le folate degli avversari che ad attaccare l’avversario stesso Un primo tempo, nel complesso equilibrato, che si chiude sullo 0-0 e che mantiene inalterate le possibilità di vittoria per entrambe le squadre. Nel secondo tempo, la partita si ravviva con tentativi che si alternano ora da una parte ora dall’altra. Al 15′, arriva il vantaggio dell’Ansel. Calcio piazzato guadagnato, con intelligenza dall’ottimo Di Cello L., cross al centro con repentino inserimento di Di Cello S. che, di testa, batte Oscuro sul primo palo, incredibilmente sguarnito. La reazione della Polisportiva si esaurisce con dei cross alti in area che diventano facile preda per Buccafurni. L’Ansel, in ogni caso, non si limita a controllare ma, attacca come e quando può, prediligendo in questa fase il contropiede col velocissimo Orlando al centro e il funambolico Arcuri sulla destra. Ottima in questa fase la disposizione tattica di Vasta che, oltre a diventare con la sua velocità un pericolo per la difesa avversaria, torna, sulla linea difensiva a protezione della stessa difesa. L’arbitro, in questa fase, comincia a perdere l’orientamento perchè fischia e ammonisce indiscriminatamente e, in alcuni momenti anche senza motivo. La paura di essere espulsi per doppia ammonizione, condiziona i giocatori della Polisportiva che mollano le strette marcature sugli avversari. Questi ultimi sono pronti ad approfittarne passando in vantaggio una seconda volta con Orlando che, questa volta, supera Oscuro in uscita, legittimando così la superiorità della sua squadra. La reazione della Polisportiva è veemente ma è frenata dall’arbitro che continua a fischiare e ad ammonire senza cognizione di fatto. Ne fanno le spese prima De Sensi, espulso per doppia ammonizione e successivamente l’allenatore Fioretti, reo di avere contestato una decisione arbitrale. Animi tesi ma, contenuti nella protesta e nei modi di protestare, sia contro il direttore di gara che contro gli avversari del resto, nessuno ci sta a perdere, ed una delle due squadre stava perdendo. Sul due a zero, la partita è praticamente chiusa e, gli estremi tentativi della Polisportiva di segnare almeno una rete, si infrangono sistematicamente sulle decisioni arbitrali che, riesce ad alterare gli animi anche al di là del dovuto. Si trova addirittura sulla traiettoria del pallone quando Landolfi, con un violento tiro inquadra la porta avversaria, salvando Buccafurni da una possibile insidia. Con questa vittoria l’Ansel conserva la testa della classifica, proponendosi non solo come squadra rivelazione ma anche come squadra compatta, tecnica e dura da battere. L’Ansel, assieme alla Nuova Curinga costituisce, per questa giornata di campionato, l’orgoglio per la comunità di Curinga. Aspettiamo di conglobare in questi trionfi anche la Polisportiva Acconia che, pur non mancando di qualità di gioco, manca attualmente nei risultati.
Er. Ga.
A palle Ferme
Incredibile ma vero: In testa alla Classifica Generale,
due matricole e una vecchia conoscenza.
Curinga 27-10-2009 Proprio così, a guidare la Classifica Generale, dopo sei giornate di campionato, troviamo: due matricole, Sporting Davoli e Ansel Acconia, ed una silenziosa ma efficace Filogaso. Una giornata che segna la fine della imbattibilità della Serrese che viene sconfitta, in modo ineccepibile ed incontestabile, dalla Nuova Curinga, in netta ripresa e impaziente di risalire la china. Deludente prestazione della Nuova Filadelfia, sconfitta in casa da un impeccabile Filogaso che, con una rete per tempo si porta a casa tre punti pesantissimi. Una battuta d’arresto che, i tifosi locali non si aspettavano me che sono costretti a rivedere le aspirazioni di partenza. Non riesce a fare di meglio il Badolato, perchè perde il derby contro il Petrizzi che, lo sorpassa in classifica e che lo costringe a rimandare a tempi migliori tutti i suoi propositi di riscatto. Cade anche la Nuova Limbadi contro uno spietato Sporting Davoli che infligge la seconda sconfitta consecutiva ai padroni di casa, dopo quella subita nel recupero del Mercoledì. Goleada del Bivongi sull’Euro Girifalco che incappa in una giornata esageratamente negativa. Con questa vittoria, il Bivongi raggiunge quota sette punti in classifica, alla pari proprio con l’Euro Girifalco. Partita ricca di emozioni quella giocata tra il San Calogero e il Real Pianopoli, con il Real in vantaggio di tre reti a zero dopo appena quindici minuti di gara e, il San Calogero che pazientemente, costruisce azione su azione, fino a raggiungere il pari finale. Sfortunato il Real Pianopoli perchè ha sbagliato, al quarantesimo del secondo tempo, un rigore che gli avrebbe potuto garantire i tre punti della gara. La magnifica Ansel Acconia, batte i cugini della Polisportiva Acconia in un derby combattuto e dal risultato finale che soddisfa pienamente la dirigenza guidata dal Presidente Sebastiano Trovato. Alla Polisportiva, per ora, manca solo il risultato perchè quello che non riesce a fare è abbinare il bel gioco ai risultati positivi. Aspettiamo tempi migliori. Infine, una nota di merito per la Nuova Valle che, battendo la Uesse Catanzaro, lascia l’ultimo posto in classifica proprio alla squadra incontrata. La Uesse Catanzaro, rimane l’unica squadra del girone che non ha ancora assaporato la gioia della vittoria.
Er. Ga.
Palla al Centro, si ricomincia.
Una possibile fuga a tre
Sporting Davoli, Filogaso, Ansel Acconia.
Curinga 29-10-2009 Buona occasione per le tre squadre di testa per tentare una fuga. La settima di campionato vede le tre squadre impegnate tutte dentro le mura amiche: lo Sporting Davoli affronterà la Serrese reduce da una sconfitta cocente subita ad opera della Nuova Curinga. Una partita tra una squadra che ha tutta l’intenzione di ritornare presto dove la ha vista protagonista e, un’altra che, pur essendo matricola della categoria, sta facendo valere tutto il suo valore a suon di gol. E’ l’occasione per verificare se la Serrese soffre le squadre forti e ne teme il confronto oppure la sconfitta subita domenica scorsa, è stata solo e soltanto una defaillance momentanea senza ripercussioni di sorta. Per lo Sporting Davoli si tratta invece di verificare se è vera forza quella manifestata fino ad ora tra le mura amiche conclude sempre con goleade eccezionali. Facile per il Filogaso che incontra una Nuova Valle che ha già subito quattro sconfitte in sei partite. E’ vero che proviene dall’entusiasmo della sua prima vittoria in campionato ma, sembra non ci siano speranze contro la squadra di casa. Impegnativa la partita che l’Ansel Acconia dovrà sostenere contro il Petrizzi, una squadra che ha già ottenuto tre vittorie e che deve ancora recuperare una partita. Temibile, quindi, la squadra di Mister Manno che domenica scorsa ha steso, anche se fortunosamente, il Badolato. L’Ansel dal canto suo, sembra avere ormai ritrovato il migliore Orlando per cui, se Arcuri e Di Cello forniscono ancora una prestazione adeguata, si può meglio sperare in quel tentativo di fuga che tutti i suoi tifosi si augurano. Anticipate al sabato due partite di entità non trascurabile; la squadra baby del Real Pianopoli ospiterà la Nuova Filadelfia di Mister Alessandro che, fino ad ora non è riuscito a dare alla sua squadra continuità nei risultati. A parte l’exploit di Badolato, per il resto, solo prestazioni mediocri. Farà visita alla Uesse Catanzaro, ultima in classifica, la Polisportiva Acconia cercando quei punti che spesso non riesce a portare a casa nonostante le buone prestazioni. La squadra di casa è l’unica a non avere ancora vinto una partita in questo campionato per cui, le speranze di vittoria per la Polisportiva Acconia sono più che fondateIl Badolato, in netta crisi, si troverà ad affrontare una temibile Bivongi che domenica scorsa ha seppellito l’Euro Girifalco con un poker da manuale. Sarà la domenica della ripresa del Badolato o dobbiamo ancora aspettare il momento della sua riscossa? Domenica sera lo sapremo. L’Euro Girifalco potrebbe approfittare del momento no del Limbadi per riprendere la via della vittoria che manca ormai da due turni consecutivi. Due sconfitte consecutive le ha subite pure il Limbadi per cui staremo a vedere chi, tra le due squadre, avrà più voglia di vittoria. Per ultima, La Nuova Curinga che, dopo la convincente prestazione contro la Serrese,ci si aspetta che arrivi qualcosa di positivo anche da San Calogero, squadra da affrontare domenica prossima. La squadra di casa ha delle risorse nascoste che, ogni tanto riesce a tirare fuori. Mi riferisco alla partita di domenica quando, sotto di tre reti, nei primi quindici minuti di gioco, è riuscita poi a riconquistarsi un risultato di parità, inizialmente insperato. Una squadra che sulla distanza è temibile ma se la Nuova Curinga ritrova il brio e il gioco spumeggiante offerto contro la Serrese, allora per i padroni di casa sarà difficile conquistare i tre punti.
Er. Ga.
S.CALOGERO 3 – 0 N. CURINGA
SAN CALOGERO: Prestia L., Pontoriero E., Mazzeo, Monteleone Giani. (38′ st Petrolo) Prestia S., Ventrice, Mazzitelli, Lo Gatto (22′ st Prestia G.), Fata, Grillo, Monteleone A. (10′ st Contartese).
In panchina: Ferrazzo, Contartese, Petrolo. Prestia G., Vicari, Monteleone S.
Allenatore: Romano
ARBITRO: Barbagallo di Cosenza
NUOVA CURINGA: Sorrentino, Riga, Pettinato, Nosdeo, Cerra, Camillò, Gigliotti, Tuoto (1′ st Martinez), Zerbonia, Marturano (20′ st Spina), Grandinetti G. (1′ st Schiavello).
In panchina: Grandinetti F., Fragalà, Schiavello, Paonessa, Spina, Martinez, Currado.
Allenatore: Spina
MARCATORI: 10’pt Monteleone A., 30′ pt Grillo (rig), 9′ st Monteleone A.
Monteleone e Grillo rifilano tre gol alla Nuova Curinga
Un San Calogero su di giri
SAN CALOGERO – Partita correttissima. Il San Calogero parte a razzo e non fa respirare gli ospiti. Infatti arrivano subito le occasioni. Al 10′ cross di Mazzei per Mazzitelli di testa, respinge Sorrentino e Monteleone segna. Un Grillo fantastico tiene in apprensione gli ospiti. Al 30′ entra in area e Cerra lo atterra. Rigore nettissimo. Al 9′ Lo Gatto taglia e serve Monteleone al volo che segna un gol bellissimo. Sul 2-0 palo di Tuoto da fuori area. Questo l’unico lampo. Sull’1-0 Lo Gatto al 23′ pt si trova a tu per tu con il portiere lanciandogliela addosso, Ventrici a porta vuota manda fuori. Al 28′ Monteleone su punizione sfiora l’incrocio. Prima dell’intervallo Fata su punizione manda fuori. Nei primi 5 minuti della ripresa la Nuova Curinga ha il predominio territoriale ma non colpisce; anzi il San Calogero colpisce in contropiede. Dopo il 3-0 Prestia si supera su Schiavello e Zerbonia. Verso il 40′ altre due occasioni per i locali: con Contartese e Prestia S. Vittoria dedicata al bomber Zappia che nei giorni scorsi e diventato papa per la prima volta.
Il Quotidiano
ANSEL ACCONIA 2 1 PETRIZZI
ANSEL A.: Buccafurni, Colloca, Muraca L., Perri, Muraca S., Di Cello S., Vasta, Morelli, Orlando, Arcuri, Di Cello L.
In panchina: Matarazzo, Perugino, Torcasio, Mercuri GF.
Allenatore: Galioto
MARCATORI: 12′ p. t. Arcuri, 25′ p. t. Vasta, 46′ s. t. Riggio
PETRIZZI: Maiolo, Sinopoli, Lagani, Daquino, Calabrese, Clasadonte, Riggio, Chiefari, Valente, Valenti, Commodaro.
In panchina: Ussia, Riitano, DeGiorgio, Lombardo, Servello, Furriolo, Muniaci.
Allenatore: Manno
ARBITRO: Sig. Zucco da Catanzaro
La formazione di Galioto regola con autorità il temibile Petrizzi
Continua la favola dell’Ansel
di BRUNO SODARO
ACCONIA Di CURINGA – Continua a vincere l’Ansel e conserva il primo posto in classifica. Una gara ben disputata dalle due formazioni. I locali, già nella prima parte della gara, realizzando due reti, avevano ipotecato la vittoria finale. Le reti. Al 10′ i padroni di casa si portano in vantaggio grazie alla rete di Arcuri che, dopo aver saltato un paio di avversari, spedisce in fondo al sacco, con un pallonetto. Il raddoppio al 22′. Vasta, che si è ristabilito in settimana, dopo l’infortunio di sette giorni fa, raccogliendo un assist di Orlando. La rete del Petrizzi, nei minuti di recupero. Riggio, su passaggio di Commodaro. Da segnalare un palo di Commodaro su assist di Lagani, al 2′ del secondo tempo.
Il Quotidiano